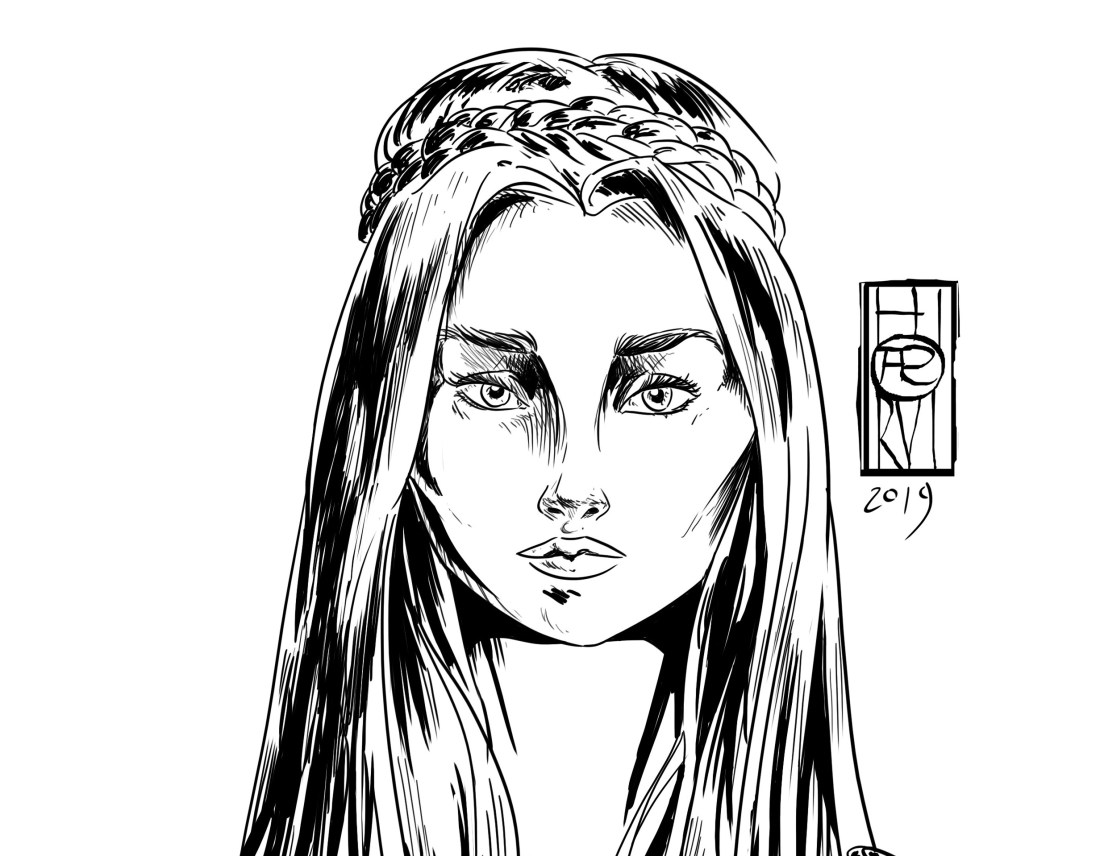Quando ero ancora un ragazzino avevo una grande passione per la paleontologia, in particolare per i dinosauri. Ricordo molto bene che mi divertivo a sorprendere il parentame sciorinando una serie di nomi scientifici di tutti quei dinosauri che colpivano la mia fantasia, dai più grossi ai più piccoli. Crescendo, questa passione si è in parte affievolita, ma non è del tutto scomparsa, anzi: provo sempre un grande piacere, quando il lavoro me lo permette, nel leggere articoli che trattano la scoperta di nuove specie, oppure che approfondiscono le teorie sull’estinzione di questi grandi e sorprendenti animali. Come molti ragazzi della mia generazione, inoltre, sono rimasto profondamente affascinato dal film Jurassic Park: in particolare, ricordo con un misto di stupore e paura i velociraptor (o meglio, la rappresentazione che se ne aveva negli anni Otttanta-Novanta) che mi colpirono per la loro ferocia e intelligenza. Fu così naturale, per me, combinare la mia passione per questi dinosauri con quella per la Terra di Mezzo. Niente paura: non ho trasformato Sauron in John Hammond (che, per chi non lo sapesse, è il miliardario che finanziò l’opera di clonazione dei dinosauri nei romanzi di Crichton e nei film di Spielberg), anche se, tuttavia, lo stesso Sauron si diletteva di quella che, oggi, chiameremmo genetica applicata (a questo proposito, ricordo che durante gli anni del Liceo, anziché scrivere il nome del prof. di biologia e chimica sul mio diario, avevo deciso di soprannominarlo Tevildo, in onore del primo nome che Tolkien aveva scelto per Sauron). Già nella Prima Era, infatti, Sauron aveva partecipato attivamente alla creazione degli Orchi nelle prigioni di Utumno e di Angband, mutando la razza degli elfi a suo piacimento; nella Seconda Era, invece, aveva dato il via all’aggressiva razza degli Orchi di Mordor (Gandalf vi accenna durante il combattimento nella Camera di Mazarbul); infine, nella Terza Era, prima della sua definitiva sconfitta, aveva creato la razza degli Olog-hai, che, a differenza dei normali troll, non temevano la luce del sole e le Cavalcature Alate dei Nazgul, una delle quali fu uccisa da Legolas poco prima che la Compagnia si sciogliesse.
Le Bestie Alate colpirono fin dal principio la fantasia degli appassionati del Signore degli Anelli: in una lettera indirizzata a Tolkien un suo lettore gli chiese se questi esseri, simili a piccoli draghi, non gli fossero stati ispirati dalla visione, in un qualche museo o in un libro sulla fauna preistorica, di una serie di rettili volanti, gli Pterosauri. D’altra parte, la somiglianza non era solo fisica (potete controllare voi stessi su Wikipedia): nella descrizione delle Bestie volanti, infatti, Tolkien accenna in modo enigmatico a un remoto passato della Terra di Mezzo, del quale non si farà poi più cenno, un passato dal quale quelle creature sarebbero giunte fino ai tempi della Guerra dell’Anello, come se si trattasse di una sorta di «fossili viventi».
Era forse una creatura di un mondo scomparso, la cui razza, sopravvisuta in montagne nascoste e fredde sotto la Luna, non si era ancora estinta, covando questi ultimi arcaici esemplari, creati per la malvagità. E l’Oscuro Signore se n’era impadronito, alimentandoli con cibi crudeli, facendoli crescere oltre la misura di ogni altro essere alato; li aveva dati ai suoi servitori da usare come destrieri. (Il Signore degli Anelli, p. 637)
Tolkien negò di essersi ispirato agli pterosauri o ad altri animali analoghi; con molta onestà, tuttavia, dopo aver verificato egli stesso la somiglianza fra le Bestie Volanti e i rettili del passato, ammise che potesse esservi un legame in tal senso.
Questo scambio epistolare, unito alla mia passione per i grandi rettili del passato, mi ha quindi ispirato questa parte della storia in cui Erfea, sollecitato da un racconto che spero i miei lettori, come il principe numenoreano, trovino affascinante, si imbarca in una perigliosa avventura, che lo vedrà fare la conoscenza di nuovi nemici.
Buona lettura!
«Naug Thalion trascorreva molto del suo tempo con Erfea e la loro amicizia fu duratura e profonda; non tutti i signori del popolo di Durin serbavano tuttavia il medesimo atteggiamento nei confronti del secondogenito e molti temevano che costui avrebbe ben presto condotto alla rovina il loro popolo. Non era forse fuggito anni addietro dalla sua patria, portando seco disgrazie e sventure ovunque si recasse? Gli elfi di Edhellond avevano subito l’attacco dei servi dell’Oscuro Signore, mentre sire Morwin e dama Elwen si erano smarriti e di essi nessuno conosceva il destino ultimo. Paura ed invidia presero il cuore di costoro, ed anche questa era opera della maligna influenza di Sauron, ché fra essi vi erano coloro che possedevano gli anelli che il Maia corrotto aveva forgiato secoli addietro nell’Eregion. Voci codarde si levarono nel seno di Khazad-Dum e l’ombra cadde sulle amene sale. Durin IV, tuttavia, cauto e riflessivo, meditava su quanto ascoltava e non lasciava mai trapelare alcuna delle sue intenzioni: accadde dunque che una mattina di Narvinye[1], il concilio del sovrano si riunisse nuovamente per ascoltare le richieste di un messaggero della stirpe di Druin[2], i cui discendenti dimoravano nell’estremo levante, tra i monti Ruurik. A tale consesso prese parte anche Erfea e nessuno osò parlare apertamente contro di lui, né egli degnava di uno sguardo coloro che sapeva denigrarlo e averlo in odio; tale fu però il corso dell’udienza, che le menti di costoro furono impegnate ad elaborare una subdola strategia, il cui fine era eliminare l’inopportuna influenza del Dunadan sulla corte del re. In principio, s’avanzò tra la folla un nano dal portamento fiero, abbigliato tuttavia di laceri vesti e ricoperto dall’infame marchio di violenze ed angherie subite in tempi recenti. La voce non venne però meno all’ambasciatore, né egli mostrava il benché minimo segno di cedimento: con grande curiosità Erfea prese ad osservarlo, ché mai aveva mirato nel corso della sua lunga esistenza un nano della casa di Druin e, sebbene egli non si fosse mai spinto così ad est, pure il suo interesse per quelle contrade sì remote non era scemato negli anni.
Tali furono le parole con le quali il messaggero esordì: “Porgo a Durin IV, erede di Durin I, colui che chiamano il Senza morte, gli omaggi del regno di Ruurik e delle stirpi di Durin il Prode e Bain il Timido! [3] Onore e gloria ai suoi eserciti e ai suoi fabbri! Giungo alla dimora di Khazad-Dum come latore, ahimè, di notizie insolite ed inquietanti!” Il volto di Durin IV, sebbene non rivelasse alcunché dei sentimenti che nutriva nel profondo del proprio cuore, parve illuminarsi all’udire parole così cortesi e ricambiato i saluti, invitò lo straniero a proseguire il suo racconto: “La mia dimora è in Ruurik, la grande catena montuosa posta nell’estremo ponente di Endor: ivi hanno dimora le genti della sesta e settima tribù da innumerevoli generazioni. Nel corso dei secoli, tuttavia, alcuni del popolo di Druin, ancor prima di giungere in codesta terra, abitarono alle pendici di un colle non distante da qui, Tumun-Gabil.” Mormorii si levarono all’udire quel nome, ché esso non era mai stato obliato ed era presagio di antiche e nuove sventure; tuttavia nessuno osò interrompere il messaggero ed egli proseguì nella sua narrazione.
“Al principio di questa era, un nano proveniente dalle Montagne Grigie, scoprì un vulcano quiescente, il cui nome nella lingua degli Eldar è Amon-Lanc[4], al di là del Grande Fiume, che gli elfi chiamano Anduin; il suo nome era Narin, signore dei nani della stirpe di Druin: coraggioso era il suo temperamento ed egli soffriva nel sapere confinati in anguste dimore i nani del suo popolo, desideroso com’era di vederne restaurata l’antica dignità e splendore. Egli si recò allora dal suo sire, Druin il Prode, il quale animato dalle medesime ambizioni del suo vassallo, pianificò il trasferimento del suo popolo nella Valle Deserta, che si estende tutto intorno ad Amon-Lanc; secondo quanto narrano le storie che il mio popolo si tramanda, essi trovarono un prezioso giacimento di laen rosso all’interno della struttura vulcanica e aumentarono in potenza e in numero, fino a costituire l’impero sì agognato da Druin e Narin. Borin, il secondogenito dello scopritore di Amon-Lanc era un grande fabbro, ché aveva appreso conoscenze dagli Eldar del regno dell’Eregion, del quale al nostro popolo non è più giunta notizia da quando l’Oscuro Sire lo distrusse secoli orsono: Borin costruì la prima fucina per lavorare i metalli alla maniera degli elfi[5], nel profondo di Tumun-Gabil ed acquisì notevole fama tra la mia gente. Nel volgere di qualche decennio, tuttavia, le aule di Tumun-Gabil divennero anguste e tra il popolo serpeggiava ribellione e insoddisfazione, ché le ricchezze non erano sufficienti per tutti, né ciascun nano godeva dei medesimi benefici: accadde dunque che Druin e la maggior parte del suo popolo intraprendessero un lungo e periglioso viaggio che avrebbe avuto termine solo nelle calde terre dei Chey[6], ove essi avrebbero edificato nuove e lussuose dimore nei monti Ruurik. Borin, tuttavia rifiutò di seguire il suo sovrano, ché egli ambiva ottenere il dominio sulla corporazione dei fabbri di Tumun-Gabil e le vene di laen rosso non erano ancora esaurite; egli restò dunque, in qualità di signore dei fabbri e trasmise la sua carica a suo figlio Torin e questi ai suoi eredi. Trascorsero numerosi secoli e il male si destò a Nargun[7], sicché i Rukhi[8] si diffusero su tutta la Terra di Mezzo, devastandola a loro piacimento: i nani di Tumun-Gabil, tuttavia, non mostrarono preoccupazioni di sorta per tali eventi, ché non temevano la minaccia di Sauron ed erano distanti dai confini del suo oscuro reame; al termine del trentesimo secolo di questa Era, tuttavia, un elfo della stirpe dei Noldor si presentò alle porte di Aman-Lanc; costui aveva nome Celedhring[9] e si narra fosse stato al seguito di Celebrimbor quando costui accolse Sauron ad Ost-in-Edhil. Quanta veritiera possa essere tale storia, io non saprei dire, ché molto tempo è trascorso da allora: tuttavia non dubito che gli intenti dell’elfo fossero malvagi, ché egli sembrava trarre diletto dal seminare discordia e rancori tra i nani: fu Dworim, erede di Borin, ad accogliere nelle sue sale il servo di Sauron e questi sedusse lui e il suo popolo, allettando i loro spiriti creativi con la promessa di forgiare gemme simili a quelle che un tempo gli elfi ammiravano ad Aman. Dworim si mostrò entusiasta della proposta di Celedhring, ché era maestro indiscusso nell’arte dei metalli e delle gemme, e gli mostrò l’impianto delle fucine. Nel volgere di un secolo i nani, coadiuvati dall’oscura arte dell’elfo corrotto, crearono la Khazad-Khezed, la gemma dei nani; così vivida era la sua superficie che alcuni dicono si potesse leggere attraverso di esse il fine delle azioni di colui che la impugnava nel proprio pugno. Ahimè! Essa non fu fonte di letizia, ché era un opera di Sauron e non una creazione spontanea: ben presto codesta gemma si impadronì delle menti dei signori dei nani, privandole dal libero arbitrio, sicché essi presero a realizzare grandi progetti, il cui fine è stato celato e poi obliato. Ignoro quale sia stata l’oscura arte che abbia permesso tale maleficio, ma essa deve essere stata potente, ché giammai volontà perversa è riuscita a domare ai propri fini il fiero popolo dei nani.” Con l’animo invero preoccupato, Erfea non notò il re ed alcuni tra i signori del suo popolo sfregarsi le mani, né tuttavia in caso contrario avrebbe potuto comprendere il significato di tale gesto, ché il segreto dei sette anelli dei nani è tale che esso viene tramandato di padre in figlio e nessun altro ne viene messo a conoscenza.
“Trascorso circa un secolo, il laen del filone di Tumun-Gabil si esaurì, poiché i fabbri l’avevano utilizzato per edificare strutture ignifughe, la cui finalità non è mai stata rivelata. Celedhring allora fuggì e si recò a Mordor ove rallegrò il suo mentore, assicurandogli di aver ottenuto quanto era nel suo scopo: i nani superstiti fuggirono verso Ruurik e al termine di tale migrazione, nelle silenziose e deserte aule di Tumun-Gabil, rimasero solo sette nani. Tra coloro che per qualche anno ancora si aggiravano nei corridoi e nei passaggi desolati dell’antica cittadella, vi era anche Dworim, consumato dalla pazzia e dalla paura, oserei dire dal terrore di dover condividere la gemma con gli altri compagni; in breve egli mise fine alle loro misere esistenze, restando così l’unico superstite di Amon-Lanc.” Durin IV allora l’interruppe: “Dici che egli fu l’unico a sopravvivere: come è possibile dunque che tu sappia questo?” “Invero, sire, allorché molti degli abitanti dell’antica cittadella fuggirono, si recarono nelle dimore della mia gente, lì ove narrarono tale storia così come l’avete testé ascoltata. I miei sovrani allestirono allora una spedizione, affinché i superstiti di Tumun-Gabil fossero costretti ad abbandonare quelle aule maledette Fui invitato a prendervi parte e con venti compagni mi misi in cammino, ignorando tuttavia quali pericoli avrei incontrato al termine del mio cammino.” Tacque, e per un attimo parve rivivere quegli attimi terribili e si portò le mani innanzi al viso; infine parlò, ma era come se egli si rivolgesse solo a sé stesso: “Giungemmo ad un enorme salone, ormai in rovina e comparso di detriti e polvere; ivi recuperammo le salme degli ultimi sei abitanti della cittadella. Infine…e qui la sua voce si fece simile ad un fioco bisbiglio…morte.”
Un mormorio di orrore si levò dalla folla dei nani presenti, ma tosto il silenzio prese a regnare nuovamente nella sala. Nori, uno tra i compagni più giovani e ardimentosi di Naug-Thalion alfine parlò: “Dove sono dunque i tuoi consanguinei? Quale orribile maleficio si è abbattuto su di loro? Parla dunque!” Lo sguardo vacuo dall’ambasciatore fissò per qualche istante l’intrepido nano, infine colui che era sopravissuto alla tragedia, frugando nelle tasche del proprio mantello, estrasse un oggetto, la cui forma in principio sembrava indistinguibile. Furono chiamati i portatori di luce e presto nella sala fu possibile scorgere quale macabro cimelio mostrasse il nano della stirpe di Druin: un artiglio era, dalla lunghezza di venti pollici circa e di colore bruno ramato: la maggior parte dei presenti scosse la testa, in preda a dubbi e sconforto; tosto tuttavia Erfea si levò dal proprio scranno e si avvicinò al nano; stupito costui lo osservò, ché non aveva mai veduto prima d’ora un Dunadan e l’isola di Elenna rappresentava per lui solo una remota leggenda: tosto allora si ritrasse, temendo che un grande male fosse caduto su di lui e che costui fosse un servo del Nemico. “Non temere Narin, figlio di Borlin! Costui è un uomo proveniente dal lontano occidente ed è un profondo conoscitore di Endor e delle sue creature. Si narra infatti che a Numenor vi siano parchi ove sia possibile osservare animali esotici, provenienti finanche dalle Terre dell’Aurora[10]. Non è forse così, Erfea?” “Sì – rispose il Dunadan – ed io stesso ho appreso il nome di strani e feroci animali che abitano tuttora nell’estremo meridione di Arda.”
Soppesò l’artiglio nella sua possente mano destra, lo accostò ai suoi occhi, infine parlò: “Non ho mai veduto nulla di simile prima d’ora. Non v’è dubbio tuttavia che Narin abbia scorto colui che se ne adornava e sia dunque in grado di descriverlo ai nostri occhi.” “Non v’è molto da dire – rispose quello, rabbuiato in volto – l’oscurità incombeva sulla grotta ed i miei sensi non scorsero alcunché. I miei compagni – e qui iniziò nuovamente a tremare – soccombettero per primi. Io menavo colpi con la mia ascia, quando ad un tratto compresi di aver colpito quell’essere; allora fuggì in luoghi che la mia mente rifiuta di rimembrare ancora. Non so – concluse – non vidi altro.”
Erfea non disse nulla, ma rifletté ancora per qualche istante: infine sguainò la spada, mentre molti nani lo guardavano allibiti e timorosi; egli tuttavia non si curò di loro, ma fissò con crescente inquietudine i bordi di Sulring emettere una luce azzurrina, al principio lieve, infine visibile a tutti coloro che erano con lui. Erfea allora sospirò e abbassata la lama, proclamò a voce alta, affinché ciascuno potesse udire le sue parole, quale fosse il suo pensiero: “Qualunque sia la creatura cui appartiene tale artiglio, essa non è figlia dei Valar, né è stata concepita dal pensiero di Eru Iluvatar.” Adesso non vi era alcun nano nella grande sala il cui sguardo si volgesse ad altri che ad Erfea ed egli proseguì: “Colui che ha trucidato i compagni di Narin è un empio servo di Morgoth, l’oscuro nemico del Mondo.” Durin IV lo fissò per alcuni istanti, non meno sorpreso dei suoi sudditi; tosto tuttavia levò alto il braccio e parlò: “Temo che il Dunadan abbia ragione, ché le lame forgiate dagli elfi si illuminano di luce propria qualora vengono a contatto con i servi del Nemico.” Qualcuno tra i nani osò tuttavia esprimere il suo dissenso apertamente: “Eppure egli è un mortale, non un erede di Feanor. A che pro costui tenta dunque di ingannarci? Gondolin è stata annientata molti secoli fa e ora più non si erge la bianca torre di Turgon. Chi è dunque costui per affermare un simile parere?” Fredda fu la risposta che Erfea gli riservò: “Non mi importa quale sia il tuo pensiero in tale frangente, Gori, figlio di Frain, dal momento che dubito tu abbia la volontà di recarti a Tumun-Gabil.” Tuttavia, anziché dimostrare risentimento per una simile affermazione, il signore dei nani proseguì: “Benissimo. Dica e faccia pure quello che costui crede: temo però che il sovrano si mostrerà meno indulgente nei tuoi confronti di quanto lo sia stato io.” Durin IV allora intervenne e con voce grave ammonì il suo vassallo: “Dimentichi forse quanto ha riferito Naug Thalion sul Dunadan? O la tua conoscenza degli artefatti elfici è venuta meno? Quanto a me ho preso una decisione e mi auguro che troverà il consenso dei presenti. In caso contrario – concluse con tono minaccioso – non vedo come l’autorità regale possa essere diversamente esercitata.” “Mio signore e voi tutti – disse Naug Thalion – che nessuno di voi dubiti di quanto affermai in passato; costui invero è Erfea, figlio di Gilnar, della stirpe degli Hyarrostar, colui che chiamano il Morluin. Egli ha sconfitto numerosi servi di Sauron e si narrano sul suo conto numerose leggende, molte delle quali a me ignote; tuttavia quanto ho visto e udito è sufficiente perché io possa dichiarare innanzi a voi che non vi è altro uomo a cui affiderei una missione tanto perigliosa, se egli lo vorrà.”
“Mio padre afferma il vero – aggiunse un giovane nano, il cui nome era Groin – nutro piena fiducia in quest’uomo ed egli è stimato da tutta la mia gente.” Grida di sfida si levarono allora dalle guardie del corpo di Gori ed essi sarebbero venute alle mani con i sostenitori di Naug Thalion se Erfea non avesse parlato: “La vostra unica ricompensa, se impugnerete le armi gli uni contro gli altri, sarà il riso crudele di Sauron! Suvvia, acquietatevi, ché è destino dobbiate adoperare altrove le vostre asce. Quanto a me, mi unirò ad una spedizione, qualora essa venga realizzata, ché molto desidero esplorare le antiche sale di Tumun-Gabil.”
Silenzio si fece allora in tutta la sala, ché nessuno ambiva volere esplorare tali luoghi: allora si levò dallo scranno Naug Thalion e parlò con rabbia: “Se nessuno dovesse assicurare la propria ascia al Dunadan, ecco che egli non avrebbe più degno motivo di essere chiamato nano di Khazad-Dum. Io partirò con Erfea, e la mia decisione è irrevocabile.” Molti nani allora mutarono parere e proclamarono di volersi unire ai due esploratori, sebbene molto temessero le ombre di Tumun-Gabil: una spedizione fu in breve tempo apprestata e Durin IV così ne salutò i membri: “Siate cauti, ché un grande male è all’opera nelle antiche aule di Amon-Lanc; non portate veco stoltizia o imprudenza, ma astuzia e coraggio: sebbene Erfea non ne abbisogni, chiunque lo desideri può procurasi l’equipaggiamento presso l’armeria reale.” Sorridevano nell’ombra i signori dei Naugrim ostili ad Erfea ed ad una futura alleanza con gli uomini, convinti che la morte avrebbe accolto tutti quei folli nel suo vuoto abbraccio qualora quelli avessero oltrepassato i cancelli di Tumun-Gabil; tuttavia dissimularono ogni ostilità e salutarono il Dunedan con rispetto: “Possa l’antica stella degli Edain e della casa di Durin rischiarare le tenebre ove giace sepolto un grande segreto!” Erfea, tuttavia, non pronunziò alcuna parola, ma si limitò ad inchinarsi, ché al suo orecchio quelle parole echeggiavano fredde e meschine.
All’alba del giorno successivo, la compagnia si mise in marcia, scendendo lungo i ripidi pendii della valle dei Rivi Tenebrosi, che i nani chiamano Azanulbizar, evitando i boschi che si aprivano sotto di loro, ché i nani temevano gli elfi e non desideravano che questi potessero in qualche modo venire a conoscenza della missione che avevano intrapreso; al tramonto, i membri della compagnia organizzarono il bivacco notturno in un ansa del Grande Fiume e tutto intorno a loro echeggiava il dolce canto dei cigni; lieto divenne allora Erfea e presto la sua voce si levò in un canto quale mai i nani avevano ascoltato fino a quel momento. A lungo essi restarono in silenzio, affascinati dalle parole che costui pronunciava, pur non comprendendone il senso. Terminato il canto, alcuni tra i più giovani applaudirono, trovandolo divertente ed allegro, mentre i più anziani meditavano in silenzio, assorti nel rimembrare l’eco delle ultime parole che dal fiume ancora saliva: infine Naug Thalion parlò: “Ho ascoltato numerosi lai nel corso della mia esistenza, tuttavia non ho mai udito nulla di sì commovente. Alcune strofe mi parvero note, mentre di altre ignoro ogni cosa: non dubito tuttavia che ella sarebbe stata lieta se avesse potuto ascoltare le tue parole.” Erfea non parve prestargli attenzione e da principio non rispose: infine parlò, e fu come se la sua voce giungesse dai flutti dell’Oceano: “Dici il vero affermando questo, dal momento che fu ella a comporre tale canzone anni addietro; aveva appreso molte cantiche dagli Eldar di Lindon e sovente si dilettava nel comporre versi e nel suonare l’arpa; mai suoni più dolci e melodiosi si udiranno in quelle terre, ché Numenor è stata occultata e giace nell’abisso invisibile agli occhi dei mortali.” Sospirò, infine tacque e parola non pronunciò più quella sera. Nei giorni successivi, dopo aver guadato con facilità l’Anduin a nord, lì ove le acque erano più basse, i nani e il Dunadan giunsero ai primi boschi che si estendevano nel Rhovanion, lì ove pochi uomini vivevano e tutto era silenzio; a lungo cercarono il sentiero che conducesse ad Amon-Lanc senza tuttavia averlo trovato, nonostante Erfea fosse abile nell’individuare le tracce dei servi di Sauron; infine, stanchi ed amareggiati, essi si distesero a terra. A lungo giacquero, senza pronunziare parola alcuna; infine Erfea sguainò Sulring, ché nel suo cuore era sorta una grande minaccia. La lama non emetteva bagliori tali da credere che il nemico fosse nelle vicinanze, tuttavia i suoi bordi splendevano fiochi nella penombra della foresta; tosto i nani si ridestarono, avendo scorto la fioca luce azzurra della spada del Dunedan: “Oscuro è il significato di quanto i miei occhi scorgono – notò Gori, un nano della stirpe di Durin – tuttavia non dubito che Erfea sarà in grado di fornire una ragione plausibile.” “Dubito che il Dunadan possa scorgere una traccia in tale foresta, prima che sorga il sole. Grande era la maestria dei fabbri di Gondolin nel forgiare spade e coltelli, tuttavia temo che questi non possano indicarci alcun percorso” disse un altro nano, il cui nome era Furin. “A quale pro ci ha condotti in tale contrada selvaggia? – inveì un terzo – dal momento che non v’è un percorso sicuro, costui dovrebbe avere il buon senso di continuare nell’esplorazione.”
Erfea però non si curava di costoro, ma osservava attentamente un cespuglio di biancospino che cresceva innanzi a lui; i suoi boccioli non si erano ancora dischiusi e pareva straziato da un immenso dolore: allora egli comprese e comandò ai nani di seguirlo in fretta altrove: lievi come elfi percorsero un miglio, inoltrandosi nella foresta ombrosa, mentre all’esterno il sole calava all’orizzonte. Infine si fermarono nei pressi di una fonte, alla quale si abbeverano avidamente. Naug Thalion fu il primo a pronunciare parola: “Mai avevo veduto un simile terrore sul volto di un uomo, Erfea Morluin! Cosa è accaduto in codesto luogo per turbarti ed indurti ad abbandonarlo sì repentinamente?” “Un grande male è all’opera qui – rispose Erfea, scuro in volto – né sono gli orchi o le belve della foresta che io temo; vi era piuttosto un’aria infetta, la quale ha reso informe e putrescente molte piante ivi cresciute.” Rabbrividì e in seguito non volle pronunciare altre parole, raccomandandosi tuttavia di vegliare a turno quella notte. La mattina seguente, Groin si accostò ad Erfea svegliandolo: “Vi è una creatura mai vista in questi boschi, Dunadan!” Erfea annuì e fu condotto dal suo compagno su un angusto sentiero, smarrito tra i possenti tronchi di querce: una serie di impronte ne marchiavano il percorso, invisibili a chi non avesse disposto di sufficiente luce per distinguerle. Entrambi gli esploratori discussero brevemente su quale comportamento sarebbe stato opportuno adottare, eppure Erfea era in preda a grandi dubbi e in balia di oscuri ricordi, ché non era la prima volta che il suo sguardo si posava su tracce simili: ciascuna di esse era lunga quanto due palmi o forse più, e all’estremità superiore si dipanava in tre sezioni minori, impresse nel limo da altrettanti artigli. Groin tuttavia comprese lo smarrimento di Erfea e ne chiese il motivo: questi tuttavia era reticente a parlare, ché tali tracce gli rimembravano la fortezza degli Ulairi posta nell’estremo Harad. Infine parlò, seppure a malincuore, ché nel suo cuore albergavano paura e nausea; cinereo divenne allora il volto di Groin ed egli non volle domandare altro: tosto allora fecero ritorno all’accampamento, ove discussero con gli altri su quanto avevano visto ed elaborarono una strategia. Erfea si sarebbe presentato innanzi al cancello di Amon-Lanc, dichiarando di essere un numenoreano nero, servo del Re Stregone, e l’anello che un tempo cingeva il dito di Adrahil e che era andato smarrito durante il combattimento, avrebbe costituito una prova valida per le sue argomentazioni. Due fra i nani avrebbero dovuto ricoprire il ruolo di prigionieri, destinati al signore del Maniero, la cui identità era fino a quel momento ignota a tutti: Naug Thalion e Groin si offrirono volontari, mentre i rimanenti compagni avrebbero atteso in quella valle per sette giorni e sette notti; qualora il Dunadan e i due signori dei nani non avessero fatto ritorno, essi avrebbero dovuto immediatamente fare ritorno a Khazad-Dum ove la notizia sarebbe stata comunicata a Durin IV».
[1] “Gennaio” nella favella degli Elfi Grigi
[2] Padre della settima casa dei nani.
[3] Padre della sesta casa dei nani.
[4] Tumun-Gabil era la traduzione nella lingua khuzdul del nome elfico Amon-Lanc, Colle del silenzio.
[5] Non è chiaro a cosa alludesse il messaggero, utilizzando tale espressione: è plausibile, tuttavia, che essa indicasse le “Fucine a freddo”, ove avvenivano la lavorazione delle leghe del galvorn, e dell’ithildin. Poco o punto è stato tramandato sul funzionamento di tali forge, ché esse scomparvero dopo che Ost-In-Edhil fu rasa al suolo e Khazad-Dum abbandonata dai nani in fuga dal Balrog, un demone dei Tempi Remoti servo di Morgoth.
[6] I Chey erano una confederazione di tribù stanziate nell’Endor centrale, ad est del Khand: bellicose e supersitiziose, adoravano i demoni della natura e gli spiriti degli antenati. Nel corso del secondo millennio della Seconda Era, furono assoggettati da Sauron attraverso l’influenza che Ren il Folle, l’ottavo in potenza fra i Nazgul, esercitò su di loro.
[7] “Mordor” nella favella dei Khazad.
[8] “Orchi”nella favella dei Khazad
[9] Celedhring nacque nella città di Gondolin centotrenta anni prima che fosse saccheggiata dalle armate di Morgoth; in seguito a tale evento, attraversò il Beleriand e giunse stremato nei pressi delle Montagne Azzurre, ove fu soccorso dai Moriquendi che ivi abitavano dai tempi remoti. Al termine della Prima Era, in preda a grande terrore per gli sconvolgimenti che seguirono la caduta di Morgoth, fuggì e di lui si perse ogni traccia per lunghi anni; tuttavia, allorché il regno dell’Eregion fu fondato, egli ritornò nell’Eriador ed ebbe la custodia delle chiavi delle aule di Ost-In-Edhil, chè era stato fabbro a Gondolin e la sua conoscenza era onorata dagli Eldar di quella contrada. Lunghi secoli trascorse Celedhring nell’Eregion, prestando scarsa attenzione alle voci che narravano del ritorno dell’Ombra ad est, ché se grande era in lui la conoscenza delle antiche arti, non meno possente era la superbia e l’invidia ed egli avversava Galadriel, ritenendola indegna del comando; sovente sobillava Celebrimbor contro di lei, fallendo tuttavia nel suo scopo, ché il figlio di Curufin l’amava teneramente, né Celedrhing era dotato di volontà sufficiente per costringerlo a mutare parere. Annatar, il Signore dei Doni, si avvide di tale sentimento e lo mutò in rancore, trovando nel Custode delle Chiavi un valido alleato per raggiungere il suo fine; al termine di numerosi colloqui, Annatar persuase Celebrimbor a proclamare decaduta la signoria di Galadriel e Celeborn sull’Eregion ed essi abbandonarono la città. Negli anni seguenti Celedhring collabrorò con Annatar e Celembrimbor alla forgiatura dei Nove e dei Sette; allorché il Signore dei Doni abbandonò la città per recarsi a Mordor, Celedrhing lo seguì e ne divenne fedele discepolo: al termine della Seconda Era non esisteva in Mordor un fabbro più abile dell’orgoglioso Noldor all’infuori di Sauron stesso ed egli aveva assunto il titolo di Custode delle Forge; durante la guerra contro Gondor progettò l’enorme trabucco con cui gli eserciti del suo signore abbatterono il cancello di Minas Ithil. In seguito, durante l’assedio a Barad-Dur, Celedhring forgiò alcune delle numerose macchine che provocarono numerose vittime nelle schiere dell’alleanza: allorché le armate dei servi di Sauron furono disperse, tuttavia, egli fu trucidato da Glorfindel e il suo spirito si allontanò dalla Terra di Mezzo.
[10] Le Terre dell’Aurora si estendono ad est di Endor; scarsamente abitate e povere di metalli e gemme preziose, furono esplorate dai Numenoreani nel corso della Seconda Era, sebbene costoro non vi avessero mai edificato insediamenti, ché una scura ombra le aduggiava ed essi ne erano impauriti: in seguito alla Caduta di Numenor, più nessun secondogenito di Endor si è recato in tali contrade e di esse si è perduto il ricordo.